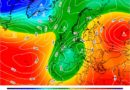Nassiriya sedici anni dopo, il ricordo del generale Scalas

a cura della redazione
Nassiriya, 12 novembre 2003. Sono le 10.39 (le 8.39 in Italia). Un camion cisterna carico di esplosivo guidato da un kamikaze scoppia davanti all’ingresso della base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei carabinieri. La prima deflagrazione provoca successivamente l’esplosione del deposito munizioni della base. Diciannove soldati morti, tra cui dodici carabinieri, questo il bilancio della strage. Perdono la vita anche nove iracheni che lavorano nella base.
All’“Operazione Antica Babilonia” prendeva parte il 151° reggimento della Brigata Sassari. L’allora colonnello Gianfranco Scalas, asseminese, era l’addetto stampa dell’Esercito. «Sono corso sul posto un quarto d’ora dopo l’attentato, potete ben immaginare la scena che mi si è presentata dinanzi agli occhi. Le persone che hanno perso la vita in quella tragedia, oltre che collaboratori, erano dei grandi amici» dichiarò Scalas in un’intervista rilasciata al nostro giornale nel 2007.
Sempre restio a parlare di quella drammatica giornata, il generale Gianfranco Scalas in occasione del sedicesimo anniversario della strage ha pubblicato uno struggente ricordo sulla sua bacheca Facebook.
«Mi trovavo nella mia stanza, intento a dare qualche qualche indicazione, quando all’improvviso sentii delle urla provenire dall’esterno. Uscii e rivolsi il mio sguardo verso il cielo, il sole ormai alto era offuscato da una nuvola nera che saliva dalla città di Nassirya. Ho sentito concitazione e urla attraverso la radio. Pochi attimi di sconcerto: è successo qualcosa di grave. Chiamai la scorta e ci dirigemmo veloci come fulmini verso la città.
Scorrevano minuti interminabili mentre il mezzo attraversava il centro abitato. Arrivati sul ponte dell’Eufrate con calcinacci e pietre che segnavano ogni metro del cammino, ci fermammo. Scesi dal mezzo, ci trovammo di fronte a quello che era il comando MSU, chiamato Animal House. Gli occhi sbarrati di fronte al fumo nero e a quelle immagini. Un carretto distrutto e il povero asinello a terra massacrato; la folla immensa che guardava si aprì per farmi passare, il vociare si tramutò in un repentino e rispettoso silenzio. Camminavo con la mia scorta, passo dopo passo sentivo la pietà e la pena degli iracheni, poi cercammo un punto per entrare nella struttura.
Passammo da dietro tra sirene ed esplosioni, sentii le urla di un maggiore dei carabinieri provenire dalla mia destra: “Colonnello vada via, vada via, è pericoloso!”. Cambiai direzione e mi avviai dalla parte opposta della struttura, incosciente nonostante gli scoppi. Camminavo tra le macerie come un automa o uno zombie, pochi metri e mi fermai annichilito riconoscendo il corpo di colui che era riverso a terra. Mi sentii senza forze nel giro di pochi secondi, il maresciallo della scorta mi strinse il braccio e disse: “Colonnello andiamo via, non è lui”. Sapevo che non era vero. Camminammo insieme, non ero in me. “Andiamo via!” disse il maresciallo e mi incamminai come un sacco vuoto verso i mezzi. Ma non potevo andare via, dovevo trovare tutti i miei uomini e costrinsi la scorta a seguirmi.
Feci il giro dalla parte del fiume tra sirene, grida, esplosioni, finché non vidi i miei due mezzi, o meglio ciò che ne era rimasto; non trovai nessuno dei miei: Ficuccello e l’autista mancavano all’appello. Riconobbi solo il regista Rolla. Dio lo abbia in gloria. Ma ormai i miei occhi erano sbarrati, increduli e ciechi di fronte allo scenario che era davanti ai miei occhi. Andai via senza animo e senza parole. Non era rimasto nulla se non l’orrore di una carneficina. Non avevo più forze, mi sentivo svuotato.
Rientrai al comando: un intero viaggio senza dire una parola, con la testa china, scioccato. Arrivato a White Horse mi avviai verso l’ufficio di Stano. Tutti capirono dal mio stato, dal mio modo di camminare, dal mio sguardo che fissava il nulla, che avevo visto il peggio che uno possa vedere. Stano mi guardò, lo guardai e scossi la testa dicendo “No! No!”. Mi abbracciò e per fortuna scoppiai in un pianto carico di tensione, liberatorio.
È stato un bene perché un comandante ha altri compiti da assolvere, il primo era la telefonata a casa per informare i familiari. Ho avuto l’ingrato compito di chiamare a casa Olla. Proseguii il mio lavoro per giorni e giorni. Non ho dormito, né mangiato per quattro giorni consecutivi, ho tenuto a bada una quarantina di giornalisti di ogni parte del mondo.
Ma era un compito da assolvere per chi non c’era più e per rendere loro gli onori che meritavano e meritano ancora oggi dopo sedici anni. Mi riposai dopo circa venticinque giorni quando mi portarono in ambulanza in ospedale. Mi risvegliai con le carezze sui miei capelli delle crocerossine che per una notte intera si susseguirono al mio capezzale.
Ho deciso di pubblicare queste righe perché dopo sedici anni credo di avere il diritto di alleggerire il mio animo. Vorrei far capire cosa è avvenuto e come un militare vive certe esperienze, perché sotto la divisa c’è un essere umano come tanti. Chi leggerà queste righe pensi solo al rispetto per chi, innocente, ha pagato con la vita la cultura della guerra e della insulsa ideologia del terrorismo.
Io sono sopravvissuto e mi sento fortunato. E finché sarà possibile, ogni 12 novembre, non dimenticherò e farò quanto possibile affinché tutti possano ricordare».